I
Fortunato e l’azienda agricola zootecnica di Gaudiano di Lavello
A
oltre novant’anni dalla sua scomparsa resta un valido punto di riferimento.
di Michele Traficante
" Ed ecco come egli espresse la sua
opinione: che chiunque sapesse far crescere due spighe di grano o due fili
d'erba, dove non ne cresceva che uno, sarebbe molto più benemerito
dell'umanità, e servirebbe molto meglio il proprio paese, che tutta la genìa
dei politici e dei politicanti messi insieme". Prendendo in prestito quest’espressione da
" Viaggi di Gulliver" di Jonathan Swift, Giustino Fortunato
rappresentò il carattere e l'opera del fratello Ernesto.
Fu un pioniere della
rinascita agricola di un'area, quel di Gaudiano di Lavello, già cara alla
malaria per l'infido Aufido, don Ernesto Fortunato, il cui ricordo, a distanza
di quasi ottantacinque anni dalla sua scomparsa, resta vivo in quanti
s'interessano di tecnica e d’innovazione nel campo agricolo.
Apparteneva ad una famiglia - come scrisse
Giustino Fortunato - " immune da quella
infingardaggine di spirito e di cuore, da quel
diritto alla infingardaggine, il quale a lungo formò e costituì il carattere
del nostro proprietario terriero".
La presenza dei
Fortunato a Gaudiano risale alla metà del '700 quali fittuari delle terre concesse loro dai vari vescovi di Melfi.
Nel 1814 acquistarono da un censuario del
Tavoliere alcune terre nella zona di Monte la Quercia. Nel 1818 acquistarono in
enfiteusi perpetua dal Tavoliere di Puglia 237 versure di terre a pascolo nella
Posta di Monte la Quercia. Tra il 1837 e il 1838 acquistarono dai fratelli
Faraone di Rionero 380 tomoli di terreno a pascolo e 50 tomoli di seminativi
ancora nella zona Posta di Monte la Quercia.
Anselmo Fortunato (1782 - 1843) nel 1839
possedeva, sempre a Gaudiano, un fondo denominato "Coppe di
Maltempo". Nel 1839, con atto notarile del 14 maggio, il vescovo di Melfi,
mons. Luigi Bovio, cedette in enfiteusi perpetua ad Anselmo Fortunato tutte le
terre della Mensa vescovile poste nell'ex feudo di Gaudiano e particolarmente
Mezzana, Geggiola, Geggiolella, Valle Principe, Lampeggiano, Maggesaria,
Finocchiaro, Finocchiello, Bosco di Gaudianello. Nel 1842 i Fortunato
acquistarono dagli Spagnoletti di Andria una vasta tenuta di terre a coltura e
a pascolo della estensione di circa 450 versure, che divenne il centro di tutta
l'azienda lavellese. In tale tenuta, intorno al 1851, è iniziata la costruzione
della palazzina residenziale, ricostruita, su progetto dell'arch.Scelzo di
Napoli, da Ernesto Fortunato sul finire del 1800.
I Fortunato operarono in
questa masseria fino al 1861. Dopo tale data, per l'imputazione di connivenza
per i moti legittimisti dell'aprile 1861, Pasquale Fortunato ( 1814 - 1879 ),
scarcerato nel 1861, con i figli Giustino ed Ernesto si trasferì a Napoli, dove
tutta la famiglia rimase fino al 1873.
La masseria di Gaudiano negli anni dal 1870 al
1873 fu tenuta in fitto da Raffaele D'Aloia di Minervino Murge per la soma
annua di 1.205 ducati.
Con l'allontanamento dei
Fortunato da Rionero anche l'azienda di Gaudiano subì un forte degrado con non
lieve pregiudizio delle finanze di famiglia.
Così sul
principio del 1873 Ernesto Fortunato, appena ventiduenne, benché avesse
conseguito nel 1870 la laurea in giurisprudenza ( come il fratello Giustino )
chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dal padre, andò a prendere possesso, per
la diretta conduzione, dell'azienda di Gaudiano " con la visione limpida e
sicura dei nuovi doveri, col deliberato proposito di essere qualcosa, di essere
innanzi tutto se stesso".
E si " inchiodò" a Gaudiano, nella
pestifera Val d'Ofanto, " con la visione limpida e sicura dei nuovi
doveri, col deliberato proposito di essere qualcosa, di essere innanzi tutto se
stesso". Oltre quarant'anni dedicati alla rinascita dell'azienda di
famiglia,
apportando impensabili
innovazioni di cultura e di gestione, facendo dell'azienda modello di Gaudiano
punto di riferimento per tanti studiosi di cose agricole. Egli intuì, innanzi
tutto, che la cerealicoltura estensiva, largamente praticata dalla maggior
parte degli agrari meridionali, non era la carta vincente. Diede vita,
pertanto, ad un notevole settore zootecnico, provando e riprovando incroci con
animali di particolare resistenza e di sicura riuscita. Soprattutto gli ovini (
dai 2000 ai 2500 capi), i suini, i bovini ( Ernesto Fortunato possedeva circa
700 capi da lavoro e da latte allo stato semibrado) costituivano la spina
dorsale dell'impresa. Dal 1876, con un
sapiente lavoro d’incrocio, prima con stalloni purosangue e poi con cavalli da
nolo Hachknej, disponendo di 80 fattrici, ottenne una pregevolissima razza
equina, la Fortunato appunto, ogni anno acquistata in blocco dall'esercito. Non
mancavano mandrie di bufali che pascolavano nelle tenute lungo l'Ofanto. Apportò
innovazioni pure nel campo agricolo. Di pari passo con la ristrutturazione
zootecnica, procedeva l'ammodernamento delle coltivazioni erbacee e arboree.
Introdusse presto l'uso di concimi, di sementi selezionate, di macchine
agricole. Mise a coltura, dopo vari esperimenti, l'erba medica ed altre
foraggiere. Aumentò l'estensione delle tenute con ulteriori acquisti: nel 1890,
la tenuta Scioscia, di 126 ettari per la captazione, tramite acquedotto, di
acque sufficienti alle necessità dell'azienda; nel 1895, la tenuta Spagnoletti,
contigua a Scioscia, di 89 ettari pagata 104.604 lire ad ettaro perché in essa
passava la strada provinciale Lavello- Minervino; nel 1909, le tenute Falcone,
Casa Colonica, Tratturiello, di 163 ettari pagate 10.000 lire circa l'ettaro;
nel 1911, la tenuta Coppicelle di Todisco di circa 202 ettari.
Ernesto Fortunato
istaurò rapporti inusuali, per quei tempi " boriosi e crudi ",
con i lavoratori. In
mezzo ai braccianti, a cui a mensa offriva pane bianco " inappagato e
secolare loro sogno", egli stava da "maestro e compagno e alla sua
tavola, abitualmente, erano solito sedere i soprastanti. Cordiali e mansueti
erano con lui i braccianti minervinesi, che pure avevano fama di irrequieti e
violenti. Erano note le pratiche contrattuali che egli intratteneva con i suoi
lavoratori. Anzitutto la consuetudine, tradizionale nella famiglia, di
pensionare i propri dipendenti con uno stabile rapporto di lavoro e addetti sia
alla gestione delle case e del patrimonio, sia alla lavorazione dei terreni,
quando non fossero più abili al lavoro. Ma soprattutto c'era la corresponsione
di salari relativamente più elevati che in ogni altra parte della Basilicata. A
Gaudiano i salariati fissi annui erano circa 80 e provenivano da Minervino
Murge e da Lavello, i primi stabilmente residenti nell'azienda. I braccianti
avventizi, specie nei periodi di punta, raggiungevano le mille unità. Ma non si
preoccupava solo delle necessità materiali dei suoi dipendenti don Ernesto, ma
anche del loro elevamento morale e spirituale. A parte la somministrazione
massiccia del chinino contro la malaria (acquistato a proprie spese dalla
farmacia Kernot di Napoli), i fratelli Fortunato, nel 1899, fecero costruire,
nei pressi della palazzina residenziale, una graziosa chiesetta (arch. Gustavo
Scelzo di Napoli) dedicata a San Pasquale Baylon, a ricordo del padre,
solennemente benedetta l'8 giugno 1900 dall'allora vescovo di Melfi e Rapolla,
mons. Giuseppe Camassa, per la regolare celebrazione delle funzioni religiose.
Qui, nel 1902, potette
ricevere il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Zanardelli, fra le
piante bonificate, il gran bosco di Gaudiano infoltito, le mandrie
ricostituite, i campi verdeggianti di colture antiche o di nuovissimo
esperimento, gli ampi caseggiati adibiti ad abitazione dei coloni o a deposito
degli attrezzi agricoli o a depositi, e le nuove cantine e, infine, nuovi volti
dei contadini.
Infaticabile,
don Ernesto, viveva per la sua azienda e non si risparmiò per assicurare
continuo progresso e miglioramento del patrimonio di famiglia, consentendo a
don Giustino di dedicarsi agli studi e alla politica. " Gran merito il mio
- confessava il grande meridionalista rionerese - studiare, viaggiare, andare a
Roma, sedere in una poltrona a Montecitorio, fare il signore. Il merito è di
mio fratello Ernesto e alla gente che lavora con lui a Gaudiano. Mio fratello,
sì, laggiù, solo nella steppa...".
Uomo schivo, libero,
tutto preso dal suo impegno di agricoltore "illuminato", don Ernesto
rifiutò onori e incarichi prestigiosi. Nel 1896, ricusò di essere commissario
del Banco di Napoli; nel 1900 di essere senatore su proposta di Salandra; nel
1906 col Gianturco, ministro dei Lavori pubblici, quella di membro del
Consiglio delle ferrovie dello Stato; nel 1912, su proposta di Francesco
Saverio Nitti, ministro dell’agricoltura, la nomina di cavaliere del Lavoro.
Questo fu l'uomo che
rigenerò la langa malarica della Valle d'Ofanto e che venne a mancare il 6
dicembre 1921 per un male incurabile all'occhio sinistro che lo costrinse, nel
1913, ad abbandonare la sua Gaudiano, ove era appena morto all'improvviso il
fratello Luigi (1857 - 1913), l'unico dei fratelli a prendere moglie (sposò
nel 1880 Isabella Giusso, da cui ebbe il figlio Pasquale, morto ad appena 5
anni e la figlia Antonia che sposò il principe Antonio Alliata di Palermo).
Dopo la sua morte fu
compianto ed onorato da molte personalità e dal popolo minuto che riconobbero
in Ernesto Fortunato un benefattore, un vero galantuomo, un vero signore.
Il consiglio comunale di
Rionero in Vulture, con delibera n° 39 del 26 aprile 1925, a riconoscimento
degli alti meriti dell'illustre concittadino, intitolò la strada, già
Savonarola, che rasenta il giardino del palazzo, già Savonarola, ad Ernesto
Fortunato. La targa stradale, nel 1946, sindaco Michele Preziuso, per una
pretesa rivalsa proletaria, giudicando Ernesto Fortunato, un gretto "
terriero", venne asportata e la strada intitolata a Giacomo Matteotti.
Nello stesso anno anche la locale scuola di avviamento professionale a tipo
agrario, già intitolata a Mauro Di Battista, ufficiale della Milizia distintosi
e perito nella guerra d'Africa nel 1935, venne intitolata a Matteotti.
Nel 1952, la maggior
parte della tenuta di Gaudiano, dell'estensione di circa tremila ettari, fu
espropriata dall' Ente Riforma e assegnata a diversi coloni. Il centro residenziale e circa 200 ettari
dell'azienda rimasero agli eredi Alliata, i quali, circa 70 anni fa, vendettero
ad alcuni privati cittadini di Lavello che si sono letteralmente spartiti i
vari locali della palazzina che il caro " piccolo santuario" di don
Giustino.

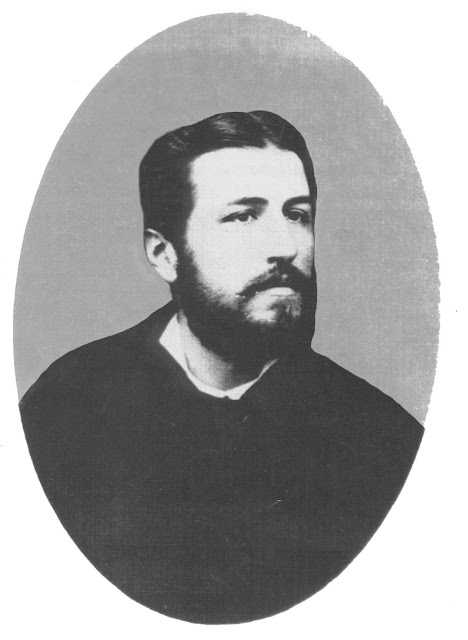


Commenti
Posta un commento